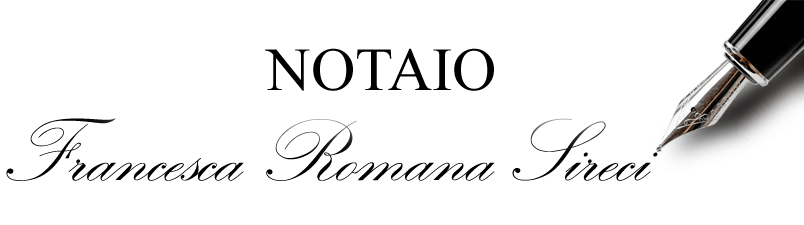News Federnotizie
Cassazione n. 2648/2026: un’interpretazione discutibile dell’art. 21 della Legge Cartabia
In questi giorni ha suscitato notevole interesse tra i notai la sentenza della Cassazione del 6 febbraio 2026, n. 2648, la quale (ai fini dell’applicabilità dell’art. 28 L. N.) ha ritenuto nullo il testamento pubblico di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, qualora questi abbia manifestato le proprie volontà al notaio con l’assistenza dell’amministratore ...
L'articolo Cassazione n. 2648/2026: un’interpretazione discutibile dell’art. 21 della Legge Cartabia sembra essere il primo su Federnotizie.
Credito d’imposta e decadenza dall’agevolazione prima casa: i termini della questione e… la questione dei termini
Esame delle Risposte AgE n. 297/2025 e n. 314/2025 A cura di Elena Peperoni e Massimo Caccavale 1. Premessa L’art. 1, comma 116, della legge di Bilancio 2025[1] – che, come è noto, ha modificato (a far corso dal 1° gennaio 2025) il comma 4 bis[2] della Nota II bis dell’art. 1, Tariffa/1 D.P.R. n. ...
L'articolo Credito d’imposta e decadenza dall’agevolazione prima casa: i termini della questione e… la questione dei termini sembra essere il primo su Federnotizie.
Contratti di rete fra professionisti e attività notarile
A cura di Massimo Saraceno 1. I contratti di rete fra professionisti: causa negoziale e programma della rete – 2. Applicazione della disciplina delle reti di impresa nei limiti della compatibilità – 3. Le reti miste – 4. I contratti di rete fra notai nel quadro delle aggregazioni notarili – 5. Impatto del nuovo codice ...
L'articolo Contratti di rete fra professionisti e attività notarile sembra essere il primo su Federnotizie.
Liberalità indirette e poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate
A cura di Garbiele Fanti 1. Introduzione In materia di accertamento delle liberalità indirette sembra oggi esservi, nella prassi degli uffici dell’amministrazione finanziaria, ma anche negli studi notarili, una diffusa convinzione di generica assoggettabilità a imposizione delle liberalità indirette contenute negli atti notarili con l’eccezione di quelle collegate ad atti contenenti trasferimenti di diritti reali ...
L'articolo Liberalità indirette e poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sembra essere il primo su Federnotizie.
La trascrizione di accettazione di eredità semplificata “a cascata”
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025) la LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 – Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita’ economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) – che entrerà in vigore il 18/12/2025. Tra le varie ...
L'articolo La trascrizione di accettazione di eredità semplificata “a cascata” sembra essere il primo su Federnotizie.
Mutui unilaterali e quietanza
La tendenza delle banche (e di altri enti finanziatori, quali, per esempio, l’INPS) è ormai quella di ricorrere allo strumento del mutuo ipotecario cd. unilaterale[1]. 1. Il procedimento A) Normalmente, il procedimento adottato è, a grandi linee, il seguente: Come ormai chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità, l’erogazione, deve ormai intendersi quale disponibilità giuridica della ...
L'articolo Mutui unilaterali e quietanza sembra essere il primo su Federnotizie.
La riforma dell’azione di restituzione: l’azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi
Sommario: 1. Premessa – 2. L’azione di restituzione contro l’erede o il legatario e i loro aventi causa – 3. L’azione di restituzione contro il donatario e la sorte di pesi e ipoteche – 4. La restituzione non opera contro gli aventi causa dal donatario. – 5. L’insolvenza del donatario – 6. La disciplina transitoria ...
L'articolo La riforma dell’azione di restituzione: l’azione di riduzione del bene donato non è più opponibile ai terzi sembra essere il primo su Federnotizie.
Agevolazione “prima casa” e prepossidenza di abitazione da alienare in due anni
Nei precedenti due articoli pubblicati su questa Rivista (“Agevolazioni prima casa: l’alienazione infrabiennale postuma” e “Credito d’imposta prima casa: chiarimenti (e conferme) dall’Agenzia delle Entrate“), in merito alla facoltà riconosciuta (dal comma 4-bis della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131 del 1986 e, a far corso dal 1° gennaio 2026, dal ...
L'articolo Agevolazione “prima casa” e prepossidenza di abitazione da alienare in due anni sembra essere il primo su Federnotizie.
La lingua degli atti notarili 112 anni dopo
Pubblichiamo la relazione svolta da Arrigo Roveda al Convegno organizzato dal Comitato Notarile Lombardo Ticinese tenutosi a Lugano lo scorso 9 ottobre 2025 dal titolo “Il Notariato dei due ordinamenti alle prese con le nuove tecnologie. Considerazioni, prospettive e casi pratici”. Il contributo ha pertanto un tono discorsivo e indicazioni prevalentemente pratiche. La lingua degli ...
L'articolo La lingua degli atti notarili 112 anni dopo sembra essere il primo su Federnotizie.
Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c.
Commento alla Sentenza n° 1947/2023 del Tribuanle di Venezia del 9 luglio 2025 Sommario: 1. La vicenda – 2. La decisione – 2.1. Accettazione espressa, accettazione tacita e acquisto dell’eredità senza accettazione – 2.2. La trascrizione dell’acquisto dell’eredità senza accettazione – 2.3. Sulla possibilità di pubblicizzare con un’unica nota di trascrizione due vicende mortis causa ...
L'articolo Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c. sembra essere il primo su Federnotizie.
Ordinanza 377/2024 della Corte di Cassazione: una nuova ipotesi di libera commerciabilità degli alloggi PEEP
A cura di Gian Marco Antonelli La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 377 del 5 gennaio 2024, afferma la non soggezione degli alloggi cc. dd. PEEP in diritto di superficie al vincolo di prezzo massimo di cessione di cui all’art. 35 co. 8. Legge n. 865/1971, ove la convenzione non indichi i criteri per ...
L'articolo Ordinanza 377/2024 della Corte di Cassazione: una nuova ipotesi di libera commerciabilità degli alloggi PEEP sembra essere il primo su Federnotizie.
La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: cos’è cambiato dopo l’intervento delle Sezioni Unite
La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà è stata nell’ultimo decennio un tema di particolare interesse, che ha più volte sollecitato l’attenzione del giurista, alimentando un vivace dibattito dottrinale. Già in auge qualche anno fa dopo il parere, reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. N. 137950 del 14 marzo 2018, con riguardo a ...
L'articolo La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: cos’è cambiato dopo l’intervento delle Sezioni Unite sembra essere il primo su Federnotizie.