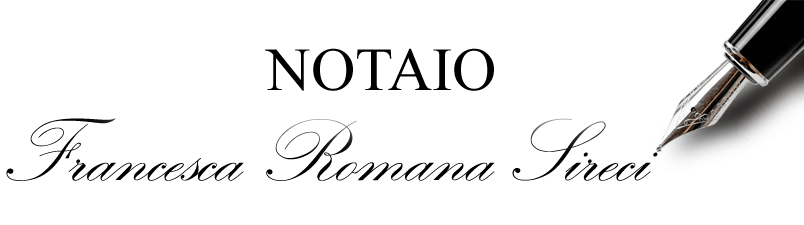Aggregatore feed
Pensione impignorabile: i limiti imposti dalla legge
Con il pignoramento della pensione è possibile trattenere una parte della pensione di un soggetto per soddisfare un debito. Ma vi sono dei limiti da rispettare.
Errori in bolletta: come presentare un reclamo?
Bisogna sempre controllare le bollette per verificare che i consumi siano corretti e che non vi siano addebiti extra. Vediamo come agire in caso di errori.
La lingua degli atti notarili 112 anni dopo
Pubblichiamo la relazione svolta da Arrigo Roveda al Convegno organizzato dal Comitato Notarile Lombardo Ticinese tenutosi a Lugano lo scorso 9 ottobre 2025 dal titolo “Il Notariato dei due ordinamenti alle prese con le nuove tecnologie. Considerazioni, prospettive e casi pratici”. Il contributo ha pertanto un tono discorsivo e indicazioni prevalentemente pratiche. La lingua degli ...
L'articolo La lingua degli atti notarili 112 anni dopo sembra essere il primo su Federnotizie.
Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c.
Commento alla Sentenza n° 1947/2023 del Tribuanle di Venezia del 9 luglio 2025 Sommario: 1. La vicenda – 2. La decisione – 2.1. Accettazione espressa, accettazione tacita e acquisto dell’eredità senza accettazione – 2.2. La trascrizione dell’acquisto dell’eredità senza accettazione – 2.3. Sulla possibilità di pubblicizzare con un’unica nota di trascrizione due vicende mortis causa ...
L'articolo Acquisto ereditario ex art. 485 c.c. e continuità delle trascrizioni: la sentenza del Tribunale di Venezia e la riforma dell’art. 2648 c.c. sembra essere il primo su Federnotizie.
Un rogito notarile può essere annullato?
Un atto pubblico redatto da un notaio può essere impugnato per chiederne l'annullamento o la nullità. Vediamo quando è possibile e come agire.
Ordinanza 377/2024 della Corte di Cassazione: una nuova ipotesi di libera commerciabilità degli alloggi PEEP
A cura di Gian Marco Antonelli La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 377 del 5 gennaio 2024, afferma la non soggezione degli alloggi cc. dd. PEEP in diritto di superficie al vincolo di prezzo massimo di cessione di cui all’art. 35 co. 8. Legge n. 865/1971, ove la convenzione non indichi i criteri per ...
L'articolo Ordinanza 377/2024 della Corte di Cassazione: una nuova ipotesi di libera commerciabilità degli alloggi PEEP sembra essere il primo su Federnotizie.
Si può rateizzare una multa stradale?
Si può rateizzare una multa, ma è necessario che sussistano determinate condizioni economiche. Vediamo allora chi può presentare tale istanza e come.
La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: cos’è cambiato dopo l’intervento delle Sezioni Unite
La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà è stata nell’ultimo decennio un tema di particolare interesse, che ha più volte sollecitato l’attenzione del giurista, alimentando un vivace dibattito dottrinale. Già in auge qualche anno fa dopo il parere, reso dall’Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. N. 137950 del 14 marzo 2018, con riguardo a ...
L'articolo La rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare: cos’è cambiato dopo l’intervento delle Sezioni Unite sembra essere il primo su Federnotizie.